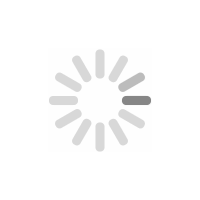Nelle scorse settimane, l’Europa e gli Stati Uniti hanno assistito ad una larga mobilitazione della comunità scientifica e accademica in contrasto ai tagli finanziari e ai licenziamenti di massa portati avanti dall’amministrazione Trump a danno di tutte le agenzie scientifiche sostenute dal governo federale. Le proteste a sostegno del National Institutes of Health (NIH), della National Science Foundation (NSF) – che è fonte, a livello federale, del 25% dei fondi destinati alla ricerca in college e università su scala nazionale – e della National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), hanno affollato le principali città statunitensi e si sono fatte strada con forza sulle principali piattaforme social, arrivando a 153 eventi organizzati in tutto il mondo in poco più di un mese.
L’iniziativa – che segue la Marcia per la scienza del 2017 – è partita dal social Bluesky, dove una dottoranda in psicologia dell’Università di Emory ha invitato scienziati, studenti e ricercatori a protestare contro misure politiche ed economiche che non solo minano la ricerca scientifica presente, ma che certamente andranno ad intaccare progressi e risultati anche in futuro.
Sono cinque gli studiosi e professionisti fondatori del gruppo “Stand up for Science”, cui si sta unendo la comunità scientifica di tutto il mondo in nome dello stesso valore condiviso: l’importanza della scienza e della ricerca di per sé, al di là del suo ritorno economico e finanziario.
Stand up for Science è solo uno dei molti esempi di contrasto alle politiche di tagli finanziari a danno della ricerca scientifica intesa in senso lato, con iniziative che vanno ad affiancarsi a quelle che, negli ultimi anni, si sono scontrate con la diminuzione dei fondi federale o statali destinati a supportare tutta quella parte di vita dello Stato che non ha a che fare (o meglio, non necessariamente) con un vantaggio economico politicamente riconosciuto e auspicato.
L’opinione pubblica ha ben individuato le ragioni politiche nascoste dietro molte delle crociate trumpiane, soprattutto nei confronti di una cultura che, in America, procede con forza in una direzione molto diversa rispetto a quella suggerita dal nuovo presidente. Lo smantellamento di un modo di pensare opposto è sicuramente parte dell’equazione del tycoon; tuttavia, la centralità di un ideale di efficienza economica dello Stato sembra addirittura superare la necessità di costruire un ambiente culturale che ricalchi perfettamente le aspettative del potere.
La sempre più evidente perdita di centralità, a livello civile e sociale, della cultura, dell’arte, della scienza e delle strutture dedicate, come scuole, laboratori, università, cinema e musei, ci aiuta ad intercettare a livello microscopico – nella nostra quotidianità, – quello che sta accadendo a livello macroscopico, negli Usa e non solo.
Nei numerosi tagli di Trump al mondo della scienza e della cultura, c’è anche quello a danno dell’Institute of Museum and Library Services (IMLS), l’unica agenzia federale che finanzia musei e biblioteche.
Ma va detto che Trump non è un’eccezione.
In un articolo di fine dicembre del Sole 24 ore, il 2025 veniva definito “l’annus horribilis della cultura in Italia”, con oltre 147 milioni di tagli al settore; pochi giorni fa, la Francia è scesa in piazza contro le misure di Bayrou che hanno visto il ministero della Cultura perdere 150 milioni di euro e, sempre tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno, alle due nazioni si è unita la Germania con il 12% di tagli per il 2025-2026.
Sono anni che assistiamo ad una decentralizzazione della cultura nella sua accezione più ampia, quella di bagaglio individuale, personalizzato dalle nostre rielaborazioni, eppure comune a tutti, perché frutto di quel sentimento condiviso che dà forma al presente.
E tuttavia lo Stato resta innanzitutto lo spazio che raccoglie, struttura e regola lo spirito del tempo che lo ospita, è l’associazione politica che permette (o dovrebbe permettere) ai propri componenti non solo di sussistere, ma di esistere, di essere portatori di desideri, valori, aspirazioni che nulla hanno a che fare con il vantaggio o con la crescita economica dello Stato stesso.
C’è uno spazio collettivo all’interno del quale il profitto ha una posizione secondaria: è lo spazio occupato, per esempio, dalle lotte sociali e civili, dalla cultura e dalla ricerca scientifica.
La verità è che oggi in Occidente si aggira un fantasma, ed è quello della cultura.
Viviamo un tempo schiacciato su se stesso, dove il progresso scientifico e culturale trova posto solamente se rivolto ad un futuro prossimo e fruttuoso e dove la ricerca è contemplata solo in termini di rendimento.
I governanti abdicano ad una parte sostanziale del loro dovere: essere i rappresentanti di una comunità che è, prima ancora che economica, politica.
Lo Stato, così come siamo abituati a pensarlo dall’Era moderna a oggi, non è la libera associazione di agenti economicamente orientati, bensì l’unione dei singoli che si fa voce comune, una molteplicità che contiene in se stessa l’incessante necessità del singolo di essere in relazione con il Tutto, in un rapportarsi continuo che assume forme diverse, variegate, che trascendono le dinamiche sterili (per quanto essenziali) dello scambio economico.
“Stand up for science”, come tutti gli altri movimenti e le iniziative che cercano di difendere la conoscenza dalla sola logica del mercato, ci permette di rispolverare un diritto del quale troppo spesso dimentichiamo l’esistenza: la possibilità di coltivare l’umanità in quanto tale, in tutte le sue forme.
La funzione politica dello Stato dovrebbe essere proprio questa: sostenere la comunità che gli dà forma spingendosi molto al di là della pura sussistenza.
In un mondo senza scienza, senza ricerca, in un mondo svuotato da quella conoscenza in grado di raccontarlo nel suo evolversi nel tempo, si aggira un altro fantasma, quello dell’uomo.
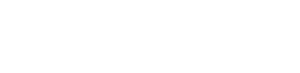



 amministrazione
amministrazione