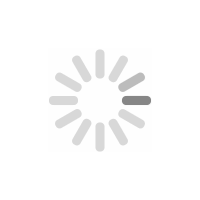“E’ facile immaginarsi le mappe tradizionali dell'America Latina, fatte di mercati che convergono verso gli Stati Uniti o, in misura secondaria, verso l'Europa. Ma le nuove rotte tracciate da Pechino - ferrovie che tagliano distanze, porti profondi come Chancay in Perù costruiti per evitare passaggi intermedi o ingombranti ritardi, strade che attraversano montagne per accorciare l'accesso ai nodi portuali - stanno spostando il baricentro”. Lo si legge in un articolo su Blue Economy del Secolo XIX a firma di Francesco Ferrari. “Dietro questo disegno c'è un obiettivo primario: assicurarsi le materie prime che alimentano le nuove frontiere dell'industria, dell'energia, dei veicoli elettrici, delle batterie. Dal litio del Triangolo andino al rame cileno e peruviano, dalla soia brasiliana fino agli idrocarburi, il Sud America è ricco di quel che la Cina vuole. Ma Pechino non si limita ad acquisti spot né a scambi mercantili. Investimenti diretti nelle miniere, partecipazioni a lungo termine, accordi vincolanti di fornitura, costruzione di impianti energetici: queste mosse riducono la vulnerabilità cinese, ampliando la capacità di prevedere, pianificare e governare la catena d'approvvigionamento”. “Per i paesi sudamericani – si legge - i vantaggi iniziali sono evidenti: nuove infrastrutture, posti di lavoro, entrate fiscali, sviluppo. Ma dietro le promesse si annidano asimmetrie. Le dipendenze verso il mercato cinese riducono la flessibilità diversificatoria. Se la Cina decide di cambiare le regole dell'importazione, di stringere le specifiche ambientali, o semplicemente se la domanda rallenta, quei paesi potrebbero restare scoperti. L'infrastrutturazione rende dure le scelte: quando si costruisce una ferrovia o si potenzia un porto per convogliare prodotti verso oriente, non è facile cambiare direzione o uso. C'è poi la questione della sovranità economica. Chi finanzia, chi possiede e chi controlla definisce, presto o tardi, non solo i bilanci, ma le decisioni politiche. Se il porto serve soprattutto i mercati cinesi, se le concessioni minerarie sono vincolate a contratti a lungo termine implicitamente modellati sulla domanda esterna, se l'accesso locale resta subordinato, le comunità, i governi locali, le élite nazionali si trovano a negoziare in uno spazio già parzialmente definito da altrui priorità. Non si tratta soltanto di diplomazia estera, ma di potere interno” e “la trasparenza spesso latita, le compensazioni ambientali e sociali restano sottodimensionate, i benefici locali si concentrano in pochi centri”. E’ stato “il vuoto lasciato da decenni di disattenzione politica e commerciale, da una cooperazione ridotta a slogan, da investimenti mai arrivati o frammentati, a offrire a Pechino lo spazio per espandersi. Stati Uniti ed Europa hanno spesso oscillato tra paternalismo e indifferenza: prima con programmi di aiuto legati a condizionalità ideologiche, poi con il progressivo disinteresse a costruire infrastrutture tangibili. Dove l'Occidente prometteva, la Cina ha costruito”. (22 set - red)
(© 9Colonne - citare la fonte)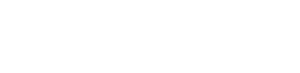



 amministrazione
amministrazione