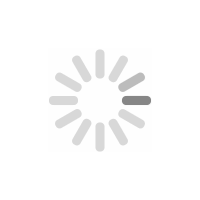“CHI HA PAURA DELLE RIFORME” DI ELSA FORNERO
Il sistema previdenziale pubblico è stato, per decenni, il grande strumento di prevenzione della povertà nell’età anziana. Ha offerto sicurezza e garanzie per un periodo della vita caratterizzato da fragilità e insicurezza. Ha mitigato i costi economici e sociali delle imponenti trasformazioni produttive degli ultimi settant’anni; ha compensato (sia pure in maniera parziale e imperfetta) i limiti del mercato del lavoro, in particolare per quanto concerne le difficoltà occupazionali di donne e lavoratori anziani. Di questo parla il libro “Chi ha paura delle riforme” di Elsa Fornero (edito da Egea Bocconi), presentato oggi al Festival dell’Economia di Trento. In Italia, ha rappresentato la via preferenziale al welfare nel suo complesso, sulla quale si sono concentrati gli sforzi delle politiche redistributive a scapito di politiche sociali più largamente presenti in altri paesi (per l’infanzia, la famiglia, contro la mancanza di reddito da lavoro). Da un punto di vista socio-politico, il sistema pensionistico è stato però anche terreno di scontro non solo sociale ma anche, in maniera meno trasparente ma non meno importante, generazionale. Si è trattato, in particolare, del luogo preferito delle promesse elettorali e della “generosità” politica miope rispetto alle grandi trasformazioni demografiche ed economiche e agli interessi di medio-lungo periodo del Paese; dell'ambito di creazione di consenso politico, attraverso la segmentazione sociale e l'attribuzione di privilegi. E’ stato anche il luogo dello scarso coraggio politico, dimostrato dalla lunghezza esasperante del processo di riforma e dalle politiche di stop and go. La trasformazione di questa istituzione, in risposta ai cambiamenti strutturali della demografia e dell’economia, è avvenuta in tutta Europa, secondo linee comuni che, lungi dal rigettare l’idea forte di “protezione sociale” degli individui, hanno impostato su basi più sostenibili e più eque il “contratto tra generazioni” sul quale essa poggia. Il processo di riforma ha interessato anche l’Italia, in misura non inferiore a quella di altri Paesi europei, ma molto più lenta e con una forte propensione ad agire in emergenza. Una “riforma” è un insieme complesso di mutamenti intrecciati tra loro, che dispiega i suoi effetti nel tempo: è un cambiamento profondo nel modo di funzionare di un meccanismo giuridico, economico, sociale, istituzionale allo scopo di adattarlo alle esigenze di rinnovamento. Nella necessità di ideare ed attuare un riforma in questo campo, dunque, il compito della politica – sostiene la professoressa Fornero – deve essere quello di rispettare i requisiti di “un buon sistema pensionistico”: l’adeguatezza (offrire un’adeguata sicurezza economica nell’età anziana, cioè un reddito socialmente sostenibile in gradi di consentire una vecchiaia dignitosa) e la sostenibilità (deve cioè essere finanziariamente sostenibile, ovvero rispettare l’equilibrio tra entrate contributive e uscite per il pagamento delle pensioni). A questi, si aggiunge anche la flessibilità, ossia la capacità di adattarsi ai cambiamenti strutturali di natura demografica, tecnologica ed economico-sociale del mondo di oggi. Le riforme vengono spesso realizzate in situazioni difficili, quando è più arduo approvarle e condividerle, ma i problemi non risolti si accumulano e indeboliscono l’economia e la società: è quindi sempre necessario contestualizzare il momento in cui sono ideate. Questo vale anche per il periodo del 2011, il governo tecnico guidato da Mario Monti, nato da una situazione di emergenza finanziaria e da un prolungato stallo politico, un’acuta crisi economica e una ossessione collettiva per lo spread. Un’analisi di quel governo – sostiene la professoressa Fornero – non solo è utile per comprendere le dinamiche del sistema italiano, ma anche per ottenere elementi adatti a una valutazione perlomeno distaccata delle azioni intraprese in quel periodo. (1 giu - PO / Red)
“IL METODO CATALANOTTI”, NUOVA INDAGINE PER MONTALBANO
Questa volta Mimì Augello se la vede brutta: nella casa dell’amata di turno rientra inaspettatamente il marito; così Mimì è costretto a calarsi dalla finestra per salvare pelle e reputazione. Da un pericolo all’altro: nell’appartamento del piano di sotto dove ha cercato riparo, nel buio intravede un corpo steso sul letto, completamente vestito e irrigidito dal gelo della morte. Di un morto ammazzato ritrovato sul letto viene informata la polizia, solo che non si tratta di quel morto, perché è in tutt’altra casa, anche lui con l’abito buono. Come può essere accaduto? E che ne è stato dell’altro cadavere? Perché tutta la scena del crimine ha qualcosa di strano che sa di teatro? Parte da questo groviglio la nuova indagine di Salvo Montalbano, raccontata da Andrea Camilleri nel romanzo “Il metodo Catalanotti” (Sellerio), ed è proprio il teatro il protagonista del romanzo; la vittima, Carmelo Catalanotti, aveva una vera passione per le scene e dedicava tutto il proprio tempo alla regia di drammi borghesi. Si era anche inventato un metodo personalissimo per mettere gli attori in condizione di recitare: affrancarli dai loro complessi, aiutarli a liberare le emozioni, una vera e propria operazione di scavo nelle coscienze. Catalanotti conservava scrupolosamente annotazioni e commenti su tutti i potenziali attori con cui veniva in contatto, oltre che appunti di regia e strani quaderni pieni di cifre e di date e di nomi… Il commissario Montalbano spulcia tutti i dossier di Catalanotti, i testi teatrali ai quali lavorava, le note sui personaggi e soprattutto il dramma che stava per mettere in scena, Svolta pericolosa. Poco a poco si lascia coinvolgere dall’indagine e dalla nuova responsabile della scientifica, Antonia, che sul commissario ha l’effetto di una calamita. Sarà proprio il teatro a fargli trovare la soluzione del doppio cadavere. Mai come in questo libro Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. E noi assistiamo alla messinscena che è dramma e commedia insieme.
PAOLO SAVONA, COME UN INCUBO E COME UN SOGNO
Al centro del dibattito di questi giorni per alcune posizioni critiche sulle modalità con le quali l'Italia ha aderito all'Euro-zona, il neo ministro degli Affari europei Paolo Savona con “Come un incubo e come un sogno. Memorialia e Moralia di mezzo secolo di storia” (Rubbettino) racconta le vicende interne e internazionali intercorse tra la prima crisi della bilancia dei pagamenti italiana del 1963 e la Grande recessione iniziata nel 2008, definite “un incubo”, termine mutuato dall’Ulisse di Joyce. Esse si sono incrociate con le numerose vicende personali dell’autore che, essendo inattese e ricche di conoscenza, lo inducono a definirle per lui “un sogno”. Lo scopo del lavoro è di trarre da questo incontro di fatti e di esperienze insegnamenti utili per affrontare problemi di natura economica di interesse generale, ma anche di presentare la sua produzione scientifica e riflettere sul significato avuto dalle sue scelte di vita, dalla Banca d’Italia, alla cattedra universitaria, alla presidenza di banche e imprese, dalla direzione generale di importanti ministeri, al Governo del Paese da Ministro dell’Industria o ora da ministro degli Affari europei. Dalla dovizia di studi ed esperienze trae due conclusioni sul perché l’Italia si dibatta in una grave crisi di crescenza e di identità: l’eccessiva ricerca della rendita da parte dei cittadini, che la politica asseconda, e la sistematica violazione della “regola della legge” a causa di una cultura individuale e sociale difettosa. La terapia che suggerisce travalica i temi dell’economia e approda ai lidi della scuola e dell’educazione, ritenute l’unico veicolo per consentire di raggiungere un’Italia e un’Europa migliori.
“PROCESSO A SOCRATE” DI MAURO BONAZZI
“Meleto, figlio di Meleto, del demo Pito, contro Socrate, figlio di Sofronisco, del demo Alopece, presentò quest’accusa e la giurò: Socrate è colpevole di non riconoscere gli dèi che la città riconosce, e di introdurre altri nuovi esseri demonici. Inoltre, è colpevole di corrompere i giovani. Si richiede dunque la pena di morte”. 399 a.C.: la città di Atene condanna a morte uno dei suoi figli più autorevoli, Socrate. Cosa è successo davvero nei mesi in cui si è svolta la vicenda giudiziaria? Si ripete spesso che si trattò di un processo politico mascherato, per colpire le simpatie oligarchiche dell’anziano filosofo. Ma forse il vero oggetto del contendere in questa vicenda fu proprio il pensiero di Socrate. Fino a che punto una comunità – ieri come oggi – può tollerare che i principi e i valori su cui si fonda siano messi radicalmente in discussione? E davvero le ragioni della filosofia e quelle della città non sono compatibili? “Processo a Socrate” di Mauro Bonazzi (Laterza) rappresenta una lettura originale di uno dei più celebri processi della storia.
GIUSTIZIA E MITO. CON EDIPO, ANTIGONE, CREONTE
Antigone, ovvero il conflitto tra coscienza individuale e ragion di stato, tra legge morale e legge positiva. Edipo, ovvero la tensione tra verità storica e oggettiva e verità soggettiva, tra domanda di giustizia e intransigenza nell’amministrarla, tra colpa, errore e responsabilità. Creonte, ovvero il contrasto tra la legge e la sua opposizione. Altrettanti dilemmi del diritto che riaffiorano continuamente nelle nostre società. Per quanto emancipata dal suo primitivo nucleo vendicativo, e oggi amministrata con molte garanzie, sancite soprattutto dalle costituzioni contemporanee, la giustizia infatti non risana mai del tutto i conti, né per le vittime né per i carnefici. Questi i temi affrontati in “Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone, Creonte” di Marta Cartabia e Luciano Violante (Il Mulino). Cartabia, professore ordinario di Diritto costituzionale, è attualmente Vice Presidente della Corte costituzionale. Per il Mulino ha pubblicato «L’Italia in Europa» (con J.H.H. Weiler, 2000) e curato «I diritti in azione» (2007), «Dieci casi sui diritti in Europa» (2011) e «La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo» (con A. Simoncini, 2010); per Oxford University Press è coautrice di «Italian Constitutional Justice in Global Context». Violante, già professore ordinario di Diritto e Procedura penale, magistrato e parlamentare, presidente della Camera dei deputati dal 1996 al 2001, è presidente di italiadecide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche. Fra i suoi libri «Politica e menzogna» (2013), «Il dovere di avere doveri» (2014) e «Democrazie senza memoria» (2017), tutti pubblicati da Einaudi.
(© 9Colonne - citare la fonte)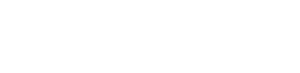



 amministrazione
amministrazione