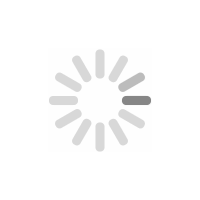Nell’estate infuocata della politica italiana, è anche l’anniversario della tragedia di Marcinelle a dividere i partiti alle prese con la campagna elettorale. A surriscaldare il clima è una lettera della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al Corriere della Sera. A proposito dell’anniversario della tragedia (era l’8 agosto del 1956 quando nella miniera belga di Bois du Cazier divampò un incendio che provocò la morte di 262 persone, di cui 136 italiani), afferma Meloni che “utilizzare la tragica ricorrenza di Marcinelle per comparazioni forzate e strumentali non è un modo corretto né di ricordare gli italiani di ieri, né di affrontare il tema degli stranieri di oggi”. Il riferimento è ai migranti che sbarcano oggi nei nostri mari: quello dell’emigrazione italiana nel mondo è un quadro, secondo la leader FdI, “radicalmente diverso da quello dell’attuale situazione dell’immigrazione verso l’Italia. La cosa più distante con la tragedia degli italiani che emigravano per lavorare nelle miniere belghe, è che molti degli immigrati irregolari di oggi, per lo più giovani maschi in età da lavoro, considerano l’accoglienza stessa come un diritto inalienabile da cui far discendere presunti diritti molto più materiali, che costano alle casse dello Stato italiano, per ogni straniero accolto, più di quanto ricevano di pensione molti nostri anziani”. Il segretario del Pd, Enrico Letta, replica direttamente da Marcinelle dove ha partecipato alla commemorazione: “Leggo un lungo articolo di critiche sul Corriere; da parte di Giorgia Meloni. Mi vien da dire che dividere invece di unire, su Marcinelle, non lo farebbe nessun capo di governo patriota che ama l’Italia”.
LA STRAGE DEGLI ITALIANI NELLA MINIERA BELGA
È il 23 giugno 1946 quando Geoffrey d’Aspremont-Lynden per il Belgio e il Conte Secco Suardo per l’Italia firmarono il cosiddetto “Protocollo Italo – Belga” che prevede l’invio di cinquantamila lavoratori italiani nelle miniere di Bruxelles e dintorni in cambio dell’invio di carbone nel Bel Paese. All’epoca nessuno avrebbe mai potuto prevederlo ma, di fatto, il disastro di Marcinelle incominciò proprio con la firma di quel protocollo. Nel 1956, anno della tragedia di cui oggi ricorre il 66esimo anniversario, erano 44mila i minatori italiani impiegati nell’estrazione di carbone in Belgio. Migliaia di persone che avevano scelto, o erano state spinte a scegliere, l’emigrazione verso quel territorio nel cuore di un’Europa che ancora si stava leccando le ferite della Seconda Guerra Mondiale. Un lavoro impegnativo, duro, spossante, per dare un futuro alle proprie famiglie e, implicitamente, favorire lo sviluppo di quella nazione che queste migliaia di persone si erano lasciate alle spalle. Un lavoro che a centinaia svolgevano dalle parti della miniera di Bois du Cazier, a Marcinelle, anche quell’8 agosto 1956. Erano da poco passate le otto del mattino quando, nella miniera, divampò un incendio causato dalla combustione di olio ad alta pressione, innescato da una scintilla elettrica. Minuto dopo minuto, la situazione divenne sempre più catastrofica, con il fuoco, le fiamme e il fumo nero che riempirono tutti i sotterranei della miniera. Il bilancio fu letteralmente drammatico: di 275 persone presenti, 262 morirono. Di queste, 136 erano italiani, tutti immigrati; si trattò della stragrande maggioranza delle vittime di quella devastante tragedia. Tra i pochissimi sopravvissuti, l’italiano Antonio Iannetta, il primo a dare l’allarme di quanto stava accadendo nel sottosuolo. Ovviamente, ci furono commissioni d’inchiesta e un processo, con sentenze miti e accordi tra le parti, mentre oggi a Marcinelle c’è un monumento a ricordare quei 136 connazionali che, nel luogo in cui avevano trovato lavoro, in quella terra che non era la loro “casa” ma nella quale stavano piantando nuove radici, avevano trovato la loro tomba. Una tragedia oltre ogni immaginazione, una ferita al cuore della memoria italiana che, anno dopo anno, stenta a rimarginarsi. Queste le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in ricordo del disastro di Marcinelle: “L’emigrazione dei nostri connazionali e il sacrificio che questa ha comportato hanno segnato l’identità dell’Italia e anche lo stesso processo d'integrazione europea. Le dolorose esperienze dei lavoratori migranti, maturate nei decenni precedenti il trattato di Maastricht, hanno sollecitato la promozione dei diritti dei lavoratori al livello europeo, contribuendo alla creazione di un’Europa coesa, solidale, fondata anche su un pilastro sociale. In questo spirito, rinnovo ai familiari delle vittime di quella tragedia e di tutti gli altri episodi che hanno tristemente coinvolto i nostri connazionali in altri contesti, i sentimenti di solidale partecipazione al loro dolore e, a tutti gli italiani che lavorano all’estero, le espressioni della riconoscenza della comunità nazionale”.
MONONGAH, DAWSON, MARCINELLE: QUANDO L’EMIGRAZIONE SI TRASFORMA IN TRAGEDIA
La tragedia di Marcinelle dell’8 agosto 1956 è senza ombra di dubbio la tragedia più nota, e maggiormente impressa nella memoria collettiva, che riguarda gli italiani all’estero. Tuttavia, non è quella che ha collezionato il maggior numero di vittime: questo triste primato, infatti, va al disastro di Monongah, nella Virginia Occidentale, il 6 dicembre 1907. Si tratta del più grave dramma minerario della storia degli Stati Uniti: alle 10.30 di quel venerdì mattina due gallerie della Fairmont Coal Company, la 6 e la 8, saltarono letteralmente in aria, con gli echi dell’esplosione che furono percepiti fino a trenta chilometri di distanza dalla miniera di carbone. Furono 171 le vittime italiane che persero la vita nelle esplosioni delle due gallerie, la maggior parte dei quali emigrati di origine molisana, calabrese e abruzzese. Sempre gli Stati Uniti sono teatro del secondo disastro minerario peggiore del Paese che, allo stesso tempo, è il secondo più grave per quanto riguarda le vittime italiane. Avvenuto sei anni dopo Monongah, il disastro di Dawson, nel Nuovo Messico, si verificò il 22 ottobre 1913, con un’esplosione nel sottosuolo che uccise 263 minatori, 146 dei quali italiani. Dieci anni dopo, sempre Dawson fu teatro di un’altra esplosione mineraria, provocata dal deragliamento di un treno carico di carbone, che costò la vita 123 lavoratori, venti dei quali nostri connazionali. Era da poco passato il nono anniversario della tragedia di Marcinelle quando, il 30 agosto 1965, un’altra tragedia colpì la comunità di emigrati italiani. Accadde tutto nell’arco di pochi secondi di un normale lunedì pomeriggio quando, alle 17.15, una valanga travolse il cantiere attorno al quale si stava costruendo la diga di Mattmark. I morti accertati furono 88, la stragrande maggioranza dei quali (56 nello specifico) erano italiani. La provincia di Belluno, con ben diciassette vittime, fu quella a piangere il maggior numero di morti. Un’altra tragedia che ha coinvolto la comunità italiana all’estero avvenne in Francia, nel 1893, con il cosiddetto “massacro di Aigues Mortes”. Il dramma si svolse tra il 16 e il 17 agosto nelle saline della Linguadoca, dove un mix di sentimento anti italiano da parte dei lavoratori francesi, alcuni scontri durante il lavoro e la diffusione di notizie false, portò a un linciaggio collettivo (sul quale restano ancora nubi di incertezza per quanto riguarda i numeri) contro gli italiani. Solo in otto sono stati identificati una volta morti: si tratta di Carlo Tasso, Vittorio Caffaro, Bartolomeo Calori, Giuseppe Merlo, Rolando Lorenzo, Paolo Zanetti, Amaddio Caponi e Giovanni Bonetto, mentre non fu mai trovato il corpo di Secondo Torchio, quello che sembrava la nona vittima certa. (red – 8 ago)
(© 9Colonne - citare la fonte)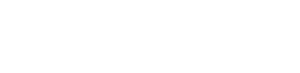



 amministrazione
amministrazione