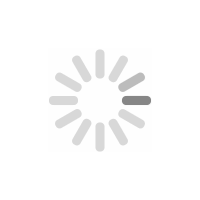La Fondazione Gorbachev, insieme a Nobel Italia, ha proposto l’artista Michelangelo Pistoletto per l’assegnazione del Nobel per la Pace. Un nome di grande rilievo, senza dubbio, e una figura che ha saputo coniugare arte, riflessione ambientale, istanze sociali e culturali. Nessuno mette in discussione il valore della sua opera, né il contributo dato attraverso la Cittadellarte e progetti come Glacial Threads, dove l’arte povera incontra la moda sostenibile, e il pensiero si intreccia con le urgenze climatiche.
Eppure, di fronte a questa candidatura, sorge spontaneo un dubbio, quasi un disagio. Non per disconoscere Pistoletto, ma per interrogarsi sul senso stesso del Nobel per la Pace oggi. È ancora giusto continuare a premiare singole personalità, spesso appartenenti all’élite culturale e intellettuale, mentre nel mondo esistono collettivi, comunità, gruppi di resistenza che ogni giorno, con il corpo e con la voce, rischiano la vita per la pace, la dignità, la libertà?
Il singolo può essere solo il volto simbolico di una moltitudine. Pensiamo ai cooperanti come Armanda Trentini o Mario Paciolla, la cui morte resta ancora avvolta nel mistero. Figure spesso escluse dai riflettori, ma che incarnano un’opera dal basso per l’affermazione dei diritti di tutti, non di pochi.
E in fondo, anche alcuni Nobel del passato sono andati a chi ha rappresentato battaglie collettive: come Rigoberta Menchú Tum, voce dei popoli indigeni e dell’ambiente; o Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi, premiati per il diritto universale all’istruzione dei bambini. Esempi di un Nobel che, pur assegnato a individui, ha riconosciuto lotte di popoli, di comunità intere.
E come non pensare oggi agli artisti palestinesi di Gaza: assediati, decimati, affamati, eppure ancora capaci di creare, persino all’aperto, tra le rovine. È lì che nasce la Biennale di Gaza, arte tra le macerie. Un evento privo di muri, ma carico di dignità, resistenza, memoria — per ora solo in video. O alla raccolta poetica Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza (Fazi Editore), testimonianza del coraggio di chi, sotto le bombe, continua a parlare, scrivere, vivere. Non è forse questa una forma autentica e urgente di pace? Non sono questi i veri operatori di pace — non teorici, ma testimoni viventi?
Oggi più che mai, un Nobel dovrebbe essere "dal basso". Non assegnato per la risonanza di un nome, ma per il peso specifico dell’impegno collettivo, quotidiano, vulnerabile e reale. Un premio a chi costruisce legami, si oppone all’odio, apre spazi comuni dove prima c’erano solo macerie. Esistono esperienze che meritano riconoscimento: il progetto delle Pietre d’inciampo, che con piccoli gesti ci impone di ricordare; oppure Il Civico Giusto, che rende visibili le scelte morali di chi, a rischio della propria vita, ha salvato altre vite. E cosa dire dei collettivi di artisti e poeti che, negli anni ’90, all’ex Mattatoio di Roma, organizzarono performance pittoriche e poetiche per sensibilizzare sull’orrore della guerra in Jugoslavia? Erano — e sono — esempi di un’arte che si fa corpo sociale, presenza politica, dialogo umano.
Perché allora non pensare a un Nobel collettivo? Un riconoscimento che non glorifichi il singolo, ma il noi che resiste, che crea, che cura. Non si tratta di contrapporre un artista ad altri. Si tratta di ridefinire il significato stesso del Premio per la Pace. Oggi più che mai, il cambiamento è un’opera collettiva. La pace non nasce da un’idea brillante, ma da un gesto condiviso. Non si afferma nei musei, ma nei luoghi feriti del mondo. Il Nobel non dovrebbe essere solo un sigillo accademico, come accade in altri ambiti, ma un faro che illumini chi, lontano dalla comfort zone dell’intellighenzia, si sporca le mani, la voce, la pelle. Per restare umano. Anche tra le rovine.
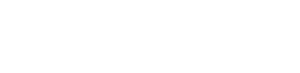



 amministrazione
amministrazione