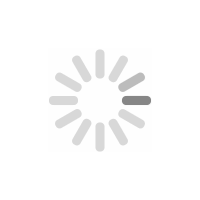“Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con la Bolivia su priorità condivise tra cui quella di combattere le organizzazioni criminali transnazionali per rafforzare la sicurezza regionale”. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con il senatore centrista Rodrigo Paz eletto alcuni giorni fa a presidente della Bolivia. Un compito non facile per un paese che conta circa 12 milioni di abitanti - su una superficie che è tre volte quella italiana - per metà contadini che per il 90% vivono al di sotto della soglia di povertà. L’economia, che fin verso la fine dell’Ottocento faceva perno principalmente sull’estrazione dell’argento, esauritasi quella ricchezza poté contare su una discreta produzione di stagno, almeno fino al crollo del prezzo di questo minerale (ottobre 1985).
La fine dell’era dello stagno fece precipitare il paese in una gravissima crisi economica con il deficit fiscale che superò il 30% del prodotto nazionale lordo mentre il crollo del settore minerario determinò una riduzione degli addetti da 30 mila a 7 mila unità. Qualche anno prima si era venuta sviluppando la produzione massiva delle foglie di coca non destinate alla tradizionale masticazione ma al mercato delle sostanze illecite per il narcotraffico. Negli ultimi anni la produzione si è assestata tra le 130 e le 150mila tonnellate delle quali solo 10mila sono destinate all’uso tradizionale masticatorio per il quale, tra l’altro, si usa un tipo di pianta dalle foglie più minute, che viene coltivata prevalentemente nelle zone di Los Yungas e di La Paz. Altre regioni tipiche della coca (questa volta a foglie grandi e spesse), sono il Chapare e il Potosì. Nell’affare sono impegnate alcune decine di migliaia di persone, per lo più contadini che, nonostante la loro povertà e ignoranza, sono consapevoli del danno sociale che la droga comporta.
Ma non sono certo i contadini a ricavare i lauti guadagni dalla coca; i prezzi al produttore non superano i 50 dollari al quintale e, al di sotto dei 30 dollari, la coltivazione non sarebbe più remunerativa. Eppure, il fatto di poter avere tre raccolti l’anno, e la relativa facilità e sicurezza della produzione, sono fattori che rendono sempre più appetibile questa attività per i contadini boliviani. Un’idea sula quantità di denaro sporco che circola in Bolivia e che deve essere “lavata”, resa legale, per poter essere goduta e investita dai trafficanti la possiamo avere dando uno sguardo alle tecniche, ai metodi, alle strade battute dai narcos per poter introdurre nei circuiti finanziari legali i loro profitti. Fino a qualche tempo fa il denaro generalmente era depositato in Svizzera, nei Caraibi o in altri paesi “sicuri”, oppure veniva inserito nella rete dei movimenti di capitali (trasporti di soldi attraverso i cosiddetti “muli”), utilizzato per transazioni o finanziamenti commerciali, investimenti in imprese, magari in fallimento, acquisto di prodotti di consumo, sia in Bolivia che all’estero. Per esempio, si comperavano (in contanti o attraverso banche compiacenti) beni immobili in altri paesi (USA o Europa),per chiedere poi prestiti bancari garantiti da questi o aspettare che i beni stessi producessero reddito attraverso affitti o con la loro vendita.
Un altro sistema piuttosto diffuso era il commercio dell’oro, in lingotti o in minerale grezzo da raffinare. Il riciclaggio attraverso l’oro è tuttora molto praticato. Negli ultimi anni, poi, con una maggiore apertura a livello commerciale e finanziario verso l’estero, sono divenute molto più agevoli le operazioni di cambio, le transazioni con valute estere e più libera, in generale, l’attività degli agenti finanziari e delle società. Questo fervore ha facilitato il lavaggio del denaro sporco ai narcotrafficanti e ai loro complici.
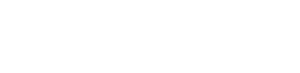



 amministrazione
amministrazione